Lavoro, libertà e quella strana felicità che non vendono
“L’uomo è arrivato quando fa per mestiere quel che farebbe gratis.”
Quello espresso da George Bernard Shaw è un ideale che tutti, almeno una volta, abbiamo sognato: trasformare il lavoro in espressione di sé. In qualcosa che ci somiglia, ci realizza, ci appassiona. Ma quanto è davvero possibile, oggi?

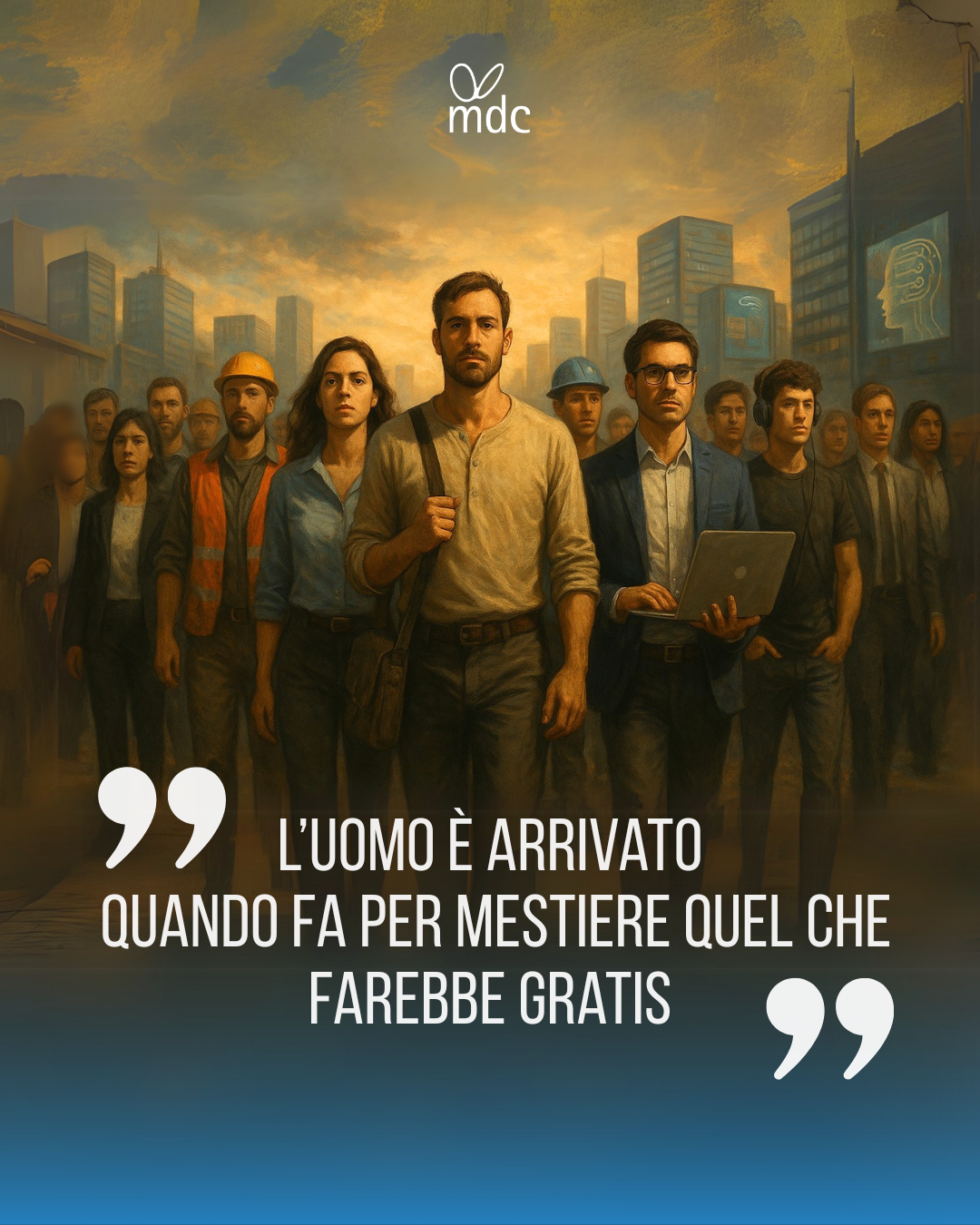
Nel 1964 il filosofo Herbert Marcuse pubblica L’uomo a una dimensione, un libro che — allora come oggi — ci sfida a guardare il lavoro con occhi più lucidi.
In una società dove il progresso tecnologico ha migliorato il benessere materiale, esiste un paradosso: siamo più comodi, ma forse meno liberi. Molti dei nostri desideri sembrano autentici, ma spesso sono adattamenti ben confezionati. Ed anche il lavoro rischia di diventare questo: un ruolo che assumiamo senza metterlo davvero in discussione. Una funzione, più che un’espressione.
Eppure, nel profondo, qualcosa ci chiama ancora. Il desiderio di dare senso a quello che facciamo. Di non essere solo efficienti, ma anche vivi. Il 1° maggio è anche questo: un invito a fermarci, a domandarci cosa significa per noi lavorare — davvero. Cosa vogliamo portare nel mondo, al di là di un cartellino timbrato o di un obiettivo raggiunto. Magari proprio lì, in quella domanda, si nasconde una forma di libertà. E anche un po’ di quella felicità che, guarda caso, non è in vendita.
Tre volti del lavoro
Forse il problema è anche nel linguaggio: diciamo “lavoro”, ma intendiamo cose molto diverse.
- C’è il lavoro-alienazione, quello di cui parlava Marx: vendita forzata di tempo, energia, libertà. Una forma moderna di schiavitù che occupa la vita intera restituendo solo il minimo per sopravvivere — e non sempre.
- C’è il lavoro-conformismo, quello analizzato da Marcuse: attività che apparentemente ci realizza, ma che in realtà ci integra in un sistema di desideri prefabbricati, dove smettiamo di chiederci *perché* facciamo ciò che facciamo.
- E infine c’è il lavoro-vocazione, quello di Bernard Shaw: qualcosa che faremmo anche gratis, perché esprime chi siamo. Raro, prezioso. Accessibile solo a chi ha strumenti, fortuna o molto privilegio.
In mezzo, aleggia l’ideologia del “lavoro rispettabile”: il mito per cui chi non lavora perde valore sociale. Così, chi è senza lavoro non si arrabbia (come forse dovrebbe), ma si vergogna. E il lavoro, da diritto, diventa identità. Da mezzo, fine.
Una trappola sottile
Il paradosso è tutto qui: Shaw immaginava un lavoro come atto creativo e libero, qualcosa che avremmo fatto comunque, anche senza paga. Marcuse ci ricorda che, invece, il lavoro può diventare una delle forme più sofisticate di conformismo moderno.
E poi c’è un’altra trappola, più sottile ma non meno insidiosa: quella che trasforma il lavoro in status symbol. Come se fare l’analista finanziario fosse più “degno” che fare il muratore. Come se lavorare per una multinazionale fosse più “qualificante” che lavorare nell’azienda di famiglia. Anche questo è conformismo, solo più elegante. E paradossalmente, chi occupa posizioni “alte” in organizzazioni complesse finisce per essere ancora più profondamente integrato nel sistema, più vincolato, più parte dell’ingranaggio.
Forse la vera Festa del Lavoro comincia proprio da qui: da un atto di consapevolezza. E da un rifiuto gentile ma fermo di quelle narrazioni tossiche che ci dicono chi vale e chi no, solo in base a un titolo di lavoro stampato su un biglietto da visita.
Nel giorno dedicato al lavoro, allora, vale la pena fermarsi e chiedersi:
Sto facendo qualcosa che farei anche gratis?
O solo quello che “qualcuno” ha deciso che dovrei fare?
